Capire e gestire l’incontinenza urinaria
L'incontinenza urinaria è una problematica medica definita dall'International Continence Society (ICS) come la perdita involontaria di urina che genera conseguenze sul piano igienico e sociale. Andiamo ad approfondire questa condizione.

L’incontinenza urinaria, definita dall’ICS come la perdita involontaria di urina che genera conseguenze sul piano igienico e sociale. insorge quando si verificano alterazioni neurofunzionali del detrusore e dello sfintere uretrale o, ancora, per via di patologie che compromettono la statica pelvica come il prolasso. Il primo passo per gestire l’incontinenza urinaria è comprenderne tutti dagli aspetti, dalle cause ai possibili trattamenti.
Anatomia e funzionalità del tratto urinario inferiore
Da un punto di vista anatomico-funzionale, il tratto urinario inferiore è costituito da:
- Vescica. Un organo cavo deputato alla raccolta per la successiva eliminazione dell’urina, che viene prodotta dai reni e giunge alla vescica attraverso gli ureteri. La sua parete è formata da tre strati: rivestimento mucoso (urotelio), strato muscolare intermedio (detrusore) e strato esterno (avventizia).
- Collo vescicale. Situato alla base della vescica, la sua integrità è fondamentale nel mantenimento della continenza urinaria.
- Uretra. Il segmento terminale del tratto urinario con specifiche caratteristiche anatomiche specifiche: lunghezza di 3,5-4 cm nelle donne; diametro di 6 mm; parete composta da tonaca mucosa e tonaca muscolare; presenza di fibre dello sfintere striato che circondano l’uretra nella porzione più vicina alla vescica e che si rapportano con le strutture della vagina nella sua porzione media.
- Pavimento pelvico. Mantiene in posizione l’uretra e gli organi pelvici. Quando, in seguito a una sua alterazione, diminuiscono i meccanismi di sospensione (fascia endopelvica) o di supporto (muscoli del perineo), insorge il prolasso.
Classificazione e tipologie dell’incontinenza urinaria
L’incontinenza urinaria è classificabile in diverse forme specifiche in base alle caratteristiche cliniche e sintomatologiche.
- Incontinenza urinaria da urgenza (Urge incontinence, UUI)
La condizione in cui si assiste ad una perdita involontaria di urine per la necessità improvvisa e improcrastinabile di urinare, nota anche come minzione imperiosa. Questa tipologia deriva da un’iperattività o iperreflessia della muscolatura vescicale (muscolo detrusore della vescica), interessando circa il 30% dei casi di incontinenza urinaria quando i meccanismi sfinteriali risultano normali.
Le caratteristiche principali includono un’origine prevalentemente idiopatica nel 90% dei casi, con maggiore incidenza nel sesso femminile, anche in giovane età. Il restante 10% è riconducibile a patologie neurologiche come demenza senile, sclerosi multipla e morbo di Parkinson, nonché a flogosi, prolasso uro-genitale o neoplasie vescicali - Incontinenza urinaria da sforzo (Stress incontinence, SUI)
Questa tipologia rappresenta la forma più frequente di incontinenza urinaria, coprendo circa il 50-60% dei casi. Si manifesta attraverso perdite involontarie di urina conseguenti ad aumenti improvvisi della pressione intra-addominale come colpi di tosse, starnuti o ponzamenti. L’incontinenza si manifesta quando, in assenza di attività contrattile del detrusore, la pressione all’interno della vescica diventa superiore a quella dell’uretra, in particolare durante momenti di aumentato sforzo addominale. In sostanza, le perdite con alla base un’insufficienza dei meccanismi di continenza vescico-uretrale si possono verificare in tutte quelle circostanze che determinano un improvviso aumento della pressione addominale come corsa, movimento ed esercizio fisico.
I fattori di rischio sono molteplici e includono condizioni fisiologiche (gravidanza, menopausa, invecchiamento) e patologiche come traumi ostetrici, chirurgici, uretriti, obesità, broncopneumopatia cronica ostruttiva, ascite, connettivopatie e neuropatie.
In base al deficit delle strutture anatomiche deputate alla continenza possono essere ulteriormente individuati due gruppi di pazienti: il primo, e più frequente, presenta un deficit di supporto anatomico dell’uretra con un’ipermobilità della giunzione uretro-vescicale; il secondo – circa il 10% dei casi – presenta un’alterazione dei meccanismi sfinterici dell’uretra. Un’ulteriore classificazione clinica, secondo Blaivas e Olsson (1988), prevede cinque gradi di severità, con gravità crescente:- Tipo 0. Anamnesi positiva per IUS (incontinenza urinaria da sforzo) ma non dimostrabile.
- Tipo II a. Collo vescicale chiuso al di sopra del margine inferiore della sinfisi pubica, discesa > 2 cm con sforzo.
- Tipo II b. Collo vescicale chiuso al di sotto del margine inferiore della sinfisi pubica.
- Tipo III. Collo vescicale ed uretra prossimale beanti a riposo in assenza di contrazioni detrusoriali (deficit intrinseco dello sfintere).
- Incontinenza urinaria mista (MUI)
Rappresenta una condizione che combina simultaneamente i sintomi dell’incontinenza da urgenza e da sforzo.
Esistono, inoltre, forme meno frequenti di incontinenza urinaria dette extrauretrali, determinate da: Malformazioni congenite come uretere ectopico o estrofia vescicale e forme acquisite caratterizzate da fistole, ossia comunicazioni patologiche tra organi pelvici. Queste ultime possono essere utero-vescicale, retto-vescicale, vagino-vescicale e vagino-uretrale.
Panoramica epidemiologica dell’incontinenza urinaria
L’incontinenza urinaria rappresenta una condizione medica con una prevalenza significativa che varia in base all’età e al genere. Nella fascia di popolazione tra i 15 e i 64 anni, si osserva che gli uomini presentano una prevalenza dal 1,5 al 5%, mentre nelle donne la percentuale si attesta tra il 10% e il 30%.
Con il progredire dell’età, l’incidenza della patologia aumenta progressivamente. Nella fase iniziale prevale l’incontinenza da sforzo, mentre nell’età geriatrica sono più frequenti le forme da urgenza.
In Italia, i dati mostrano una situazione articolata: nelle donne tra 31 e 40 anni, circa il 40% ha sperimentato episodi di incontinenza urinaria. Alla soglia dei 60 anni il 55% presenta un’incontinenza transitoria, il 25% manifesta un’incontinenza significativa (due episodi mensili) e il 15% sperimenta un’incontinenza importante (almeno un episodio giornaliero).
Tra gli over 60 che vivono in ambito familiare, la prevalenza di incontinenza urinaria oscilla tra il 15% e il 35%. Nei contesti ospedalieri, la situazione degli anziani risulta più critica: la prevalenza generale è almeno del 50%, mentre per le donne in casa di riposo i tassi raggiungono il 50-58%.
Gli studi scientifici, poi, evidenziano un legame significativo tra gravidanza e incontinenza urinaria:
- 65% delle donne con incontinenza riferisce l’esordio durante la gravidanza o nel post-partum.
- Le percentuali di incontinenza in gravidanza variano dal 17% al 54%.
- 31% presenta sintomi nel post-partum.
- La frequenza aumenta progressivamente durante la gestazione, raggiungendo il picco massimo intorno al termine, interessando circa il 12% dei casi.
Quali sono i fattori di rischio dell’incontinenza urinaria?
I principali fattori che possono innescare l’incontinenza urinaria vanno a compromettere l’apparato muscolare e la tonicità del pavimento pelvico. Nello specifico, parliamo di :
- Invecchiamento e menopausa.
- Gravidanze multiple.
- Pregressi interventi chirurgici ginecologici.
- Obesità.
- Patologie neurologiche o psichiatriche.
- Attività lavorative con sollevamento di carichi pesanti.
Quali sono i sintomi dell’incontinenza urinaria?
I sintomi che possono indicare una debolezza del pavimento pelvico e preludere all’incontinenza urinaria comprendono:
- Perdite di urina in seguito a sforzi, colpi di tosse o starnuti.
- Necessità urgente di raggiungere il bagno con difficoltà di continenza.
- Forte necessità e/o difficoltà a trattenere la minzione, soprattutto in presenza di stimoli uditivi come l’acqua che scorre.
- Dopo il bagno, sensazione di residui di acqua nella vagina.
Diagnosi dell’incontinenza urinaria
La diagnosi dell’incontinenza urinaria rappresenta un processo articolato e metodico che si sviluppa attraverso diverse fasi. Il medico, nel corso del colloquio clinico, effettua un’anamnesi dettagliata volta a identificare potenziali fattori di rischio, come pregresse gravidanze, numero ed espletamento dei parti, interventi chirurgici pregressi o terapie pelviche. Un’accurata visita generale e ginecologica consente di valutare lo stato del perineo, analizzandone il tono muscolare, i riflessi e la presenza di eventuali prolassi genitali.
Il percorso diagnostico prevede l’utilizzo di diversi strumenti valutativi:
- Diario minzionale. Un registro dettagliato in cui il paziente annota frequenza, volume delle minzioni e correlazione con l’assunzione di liquidi.
- Esame delle urine ed eventuale urinocoltura.
- Test del pannolino (Pad test). Procedura semplice ed economica per quantificare le perdite urinarie. Prevede l’utilizzo di un pannolino dal peso noto, dopo aver riempito la vescica con 250 ml; il paziente esegue una serie di esercizi e sforzi, quindi si pesa di nuovo il pannolino per misurare l’entità delle perdite.
- Q-tip test. Valutazione della mobilità uretrale nelle pazienti con incontinenza da sforzo. Mediante l’inserimento di una sonda nell’uretra, si misurano gli angoli tra l’asse uretrale e la linea orizzontale, sia a riposo che durante la manovra di Valsalva. I valori normali oscillano tra -10° e +30°; quest’ultimo valore non deve essere superato sotto sforzo.
- Test urodinamici. Indagine approfondita che studia lo svuotamento vescicale, le resistenze uretrali, la funzione detrusoriale e le possibili interferenze neurologiche identificando l’esatta eziologia dell’incontinenza.
A questi test si possono aggiungere esami contrastografici come:
- Rx Cistografia. Descrive la vescica, la sua posizione anatomica e l’eventuale discesa del collo vescicale e dell’uretra prossimale sotto sforzo.
- Rx Urografia. valuta le alte vie urinarie, il decorso degli ureteri e la vescica. Quanto emerge da questo esame risulta importante per un eventuale intervento chirurgico
In cosa consiste la terapia per l’incontinenza urinaria?
La terapia dell’incontinenza urinaria si articola su tre livelli principali: conservativa, farmacologica e chirurgica.
L’approccio conservativo rappresenta la prima linea di trattamento per tutte le forme di incontinenza. Caratterizzato da un intervento sullo stile di vita, richiede una collaborazione attiva del paziente e non presenta effetti collaterali. Gli interventi principali includono:
- Riduzione del peso corporeo nelle pazienti affette da obesità.
- Rieducazione vescicale (Bladder training) e svuotamento della vescica ogni tre ore durante la giornata.
- Esercizi del pavimento pelvico (PFMT – Pelvic Floor Muscle Training), una tecnica mirata al rinforzo muscolare specifico.
- Biofeedback. Un trattamento riabilitativo che fornisce, attraverso input uditivi e visivi, informazioni sul controllo motorio del pavimento pelvico.
- Coni di Plevnik. Si tratta di coni di peso crescente introdotti in vagina: la paziente, attraverso la contrazione della muscolatura pelvica, deve evitarne la caduta.
La terapia farmacologica, principalmente indirizzata al trattamento della vescica iperattiva, prevede antimuscarinici ed estrogeni topici. Questi ultimi vengono utilizzati per migliorare la vascolarizzazione, il tono e il trofismo della muscolatura cervicouretrale.
Le terapie chirurgiche, infine, prevedono due tipo di interventi:
- Neuromodulazione Sacrale (FDA). Indicata nei casi di urgenza minzionale resistente alle terapie conservative e farmacologiche. Prevede l’impianto di un “pacemaker vescicale” che fornisce impulsi elettrici. Regolando i segnali nervosi si va a ripristinare l’inibizione detrusoriale nella fase di riempimento, migliorando così l’intervallo minzionale e la capacità di regolare lo stimolo.
- Trattamento chirurgico. L’obiettivo principale è ripristinare la funzionalità dell’apparato sfinterico dell’uretra e riposizionare l’uretra e la vescica per favorire il meccanismo di continenza. Le tecniche principali sono: colposospensioni (interventi di sospensione della vescica a livello delle strutture pelviche solide) e stabilizzazione “tension free” dell’uretra media attraverso il posizionamento di sling in polipropilene (fionde di tessuto che abbracciano e comprimono l’uretra) con tragitto retropubico o transotturatorio.
Come si previene l’incontinenza urinaria?
La prevenzione dell’incontinenza urinaria passa attraverso accorgimenti quotidiani mirati alla salvaguardia del pavimento pelvico. A questo proposito, è fondamentale non stressare lo stimolo e non posticipare le minzioni, così come mantenere un peso forma per ridurre lo stress sul pavimento pelvico.
Altre indicazioni utili per la prevenzione di questa problematica includono:
- Evitare il fumo.
- Limitare l’assunzione di caffeina e teina.
- Assumere una dieta ricca di fibre ed introdurre abbondanti liquidi (1,5-2 litri al giorno), andando così a combattere la stipsi, che rappresenta un danno e uno stress per le strutture pelviche.
- Evitare sforzi che aumentino eccessivamente la pressione addominale.
- Eseguire esercizi per i muscoli perineali in caso di gravidanza e dopo il parto.
La tonificazione dei muscoli del pavimento pelvico attraverso l’esercizio fisico mirato consente non solo di prevenire l’incontinenza urinaria, ma anche di migliorare la circolazione pelvica e contrastare altre patologie associate come stitichezza, disturbi sessuali ed emorroidi.
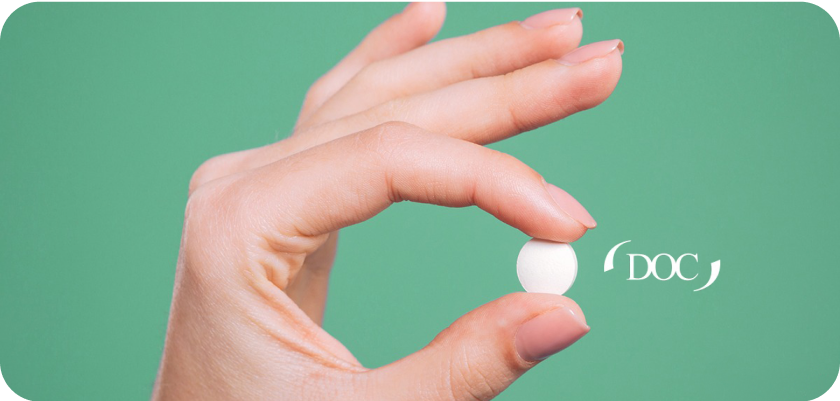
Ci impegniamo ogni giorno per garantire l'accessibilità a farmaci di alta qualità.
Scopri di più su DOC
